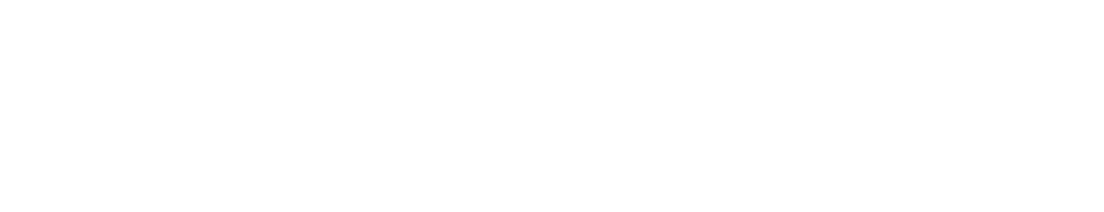Cosa cambia negli accordi verticali tra imprese
Il Regolamento UE n.330 del 2010 di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali è scaduto il 31 maggio 2022. In particolare, il Regolamento esentava dalle regole di concorrenza –
definite dall’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) – alcune categorie di accordi conclusi tra imprese operanti su livelli diversi della stessa filiera produttiva, nella catena di produzione o distribuzione (es. contratti di distribuzione esclusiva, selettiva, franchising, ecc.).
Il 1° giugno 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n.2022/720 di esenzione per categoria di accordi verticali (Vertical Block Exempion Regulation – VBER) accompagnato dalle nuove Linee Guida n.2022/C 248/01 (Guidelines), disciplina che trova immediata applicazione per i contratti sottoscritti successivamente a tale data mentre, per i contratti in vigore al 31 maggio 2022, le imprese hanno tempo fino al 31 maggio 2023 per adeguare quegli accordi verticali che non soddisfano le condizioni di esenzione previsti nel nuovo Regolamento.
La nuova disciplina (VBER e Guidelines) è il risultato di un approfondito processo di consultazione e revisione da parte della Commissione Europea con le parti interessate durato 2 anni, a seguito di un contesto imprenditoriale rimodellato soprattutto dalla crescita del commercio internazionale e delle vendite online e fornisce a tutte le imprese regole e orientamenti più semplici, chiari e aggiornati utili a valutare la compatibilità dei loro accordi verticali (di fornitura e distribuzione) con le regole di concorrenza dell’UE. Sul punto infatti, nonostante il chiaro intento di garantire maggiore flessibilità ai sistemi distributivi, la portata delle novità introdotte richiede una revisione complessiva degli accordi aziendali di distribuzione e agenzia da parte delle imprese.
I principali cambiamenti della nuova disciplina incidono soprattutto sull’adeguamento della zona di sicurezza (safe harbour) prevista dalla precedente disciplina.
E’ stato ristretto il campo di applicazione della zona di sicurezza, ad esempio, in alcuni aspetti della doppia distribuzione (ove il fornitore vende i propri beni o servizi sia attraverso distributori indipendenti che clienti finali, operando di fatto in regime di concorrenza diretta con i propri distributori) e alcuni tipi di obblighi di parità di condizioni tra offerte su canali di vendita di terze parti (piattaforme) o canali di vendita diretta del venditore (proprio sito web) non saranno più esentati ai sensi del nuovo Regolamento ma dovranno essere valutati individualmente ai sensi dell’art. 101 del TFUE.
E’ stata per contro ampliata la portata del campo di applicazione della zona di sicurezza (safe harbour) per quanto riguarda alcune restrizioni della capacità di un distributore di rivolgersi attivamente a singoli clienti (vendite attive) e alcune pratiche relative alle vendite online (la capacità di addebitare allo stesso distributore prezzi all’ingrosso diversi per i prodotti da vendere online e offline e la capacità di imporre criteri diversi per le vendite online e offline nei sistemi di distribuzione selettiva.
Una novità rilevante è l’introduzione di una nuova previsione che esclude dall’esenzione gli scambi di informazioni fra fornitore e distribuire laddove non siano direttamente connessi all’esecuzione dell’accordo, ovvero non strettamente necessari per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto.
Per quanto concerne la fissazione dei prezzi di rivendita (resale price maintenance o RPM) la nuova disciplina continua a qualificare la pratica di imposizione verticale del prezzo di rivendita – da parte del produttore ai propri rivenditori – come restrizione fondamentale della concorrenza (hard core restriction) e dunque vietata. Ciononostante, le nuove Linee Guida individuano alcuni casi eccezionali ammissibili in cui le pratiche di resale price maintenance – da valutarsi caso per caso con una analisi ad hoc – possono comportare vantaggi in termini di efficienza (§ 197 a, b, c, d delle Linee Guida, quali a titolo esemplificativo il lancio di un nuovo prodotto ovvero una campagna di breve termine –dalle 2 alle 6 settimane – di prezzi bassi).
Sono da considerarsi comunque una forma indiretta di resale price maintenance le pratiche di fissazione da parte del produttore di prezzi minimi pubblicizzati (minimum advertised price policies o MAP’s).
Una rilevante novità riguarda l’esclusione dalla categoria delle hard core restrictions (e dunque vietate) la pratica della doppia tariffazione (dual pricing) vale a dire la fissazione da parte del produttore, nei confronti dello stesso distributore, di prezzi all’ingrosso diversi per le vendite online e offline, a condizione che la differenza di prezzo sia giustificata dai diversi investimenti sostenuti e che sia finalizzata a premiare un adeguato livello di investimenti del canale online e offline.
Inoltre, con riferimento al divieto ovvero alle restrizioni relative all’utilizzo di marketplace di terze parti, in linea con la giurisprudenza Coty (https://studio-bressan.com/la-sentenza-coty/) le Linee Guida stabiliscono l’ammissione in linea di principio di tale divieto in quanto limita di fatto solo una delle modalità di vendita online utilizzabili dal distributore, a condizione che tale restrizione non abbia tuttavia l’oggetto o l’effetto di impedire l’uso effettivo della rete per la vendita dei beni e/o servizi contrattuali.
Questa in linea generale una panoramica delle novità introdotte, che tuttavia non esaurisce l’analisi della copiosa e complessa nuova disciplina e che va attentamente analizzata avendo a mente da una parte i desiderata dell’azienda ed il sistema distributivo scelto e concretamente operato dalla stessa e dall’altra i singoli rapporti e contratti di fatto in essere, le pratiche e le consuetudini non formalizzate, oltre ai diversi contratti di rivendita, distribuzione o agenzia sottoscritti.
Per maggiori info e ulteriori approfondimenti visita il sito dello STUDIO LEGALE BRESSAN